Funes il Memorioso
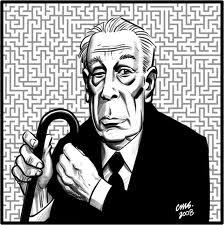
“Funes o della memoria” (“Funes el memorioso”, tratto da Ficciones, 1944) è un amaro racconto di Jorge Luis Borges nel quale si narra la storia, ambientata in Uruguay a fine Ottocento, di un giovane, Ireneo Funes, la cui condanna è quella di avere una prodigiosa memoria che gli permette di cogliere ogni dettaglio di tutto ciò che lo circonda. Il “cronometrico Funes” è un giovane uruguayano dai tratti indiani, un tipo bislacco e taciturno, la cui vicenda viene resa da un narratore identificabile con l’autore. Se da un lato Funes riesce a ricordare ogni cosa con estrema facilità, dall’altro non è in grado di formulare idee generali, la sua memoria registra solo particolari e non concetti compiuti. Questa condizione lo conduce, infine, all’isolamento e all’incomunicabilità:
“Aveva imparato l’inglese, il francese, il portoghese, il latino. Sospetto, tuttavia, che non fosse molto capace di pensare. Nel mondo sovraccarico di Funes, non c’erano che dettagli, quasi immediati”.
Funes è una riflessione sulle incertezze della memoria, l’uomo, infatti, non può ricordare tutto, pena la fine, come Funes, che muore realmente per congestione polmonare, ma simbolicamente schiacciato dal peso dei suoi ricordi:
“Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes: tutti i tralci, i grappoli e gli acini d’una pergola. Sapeva le forme delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro che aveva visto una sola volta, o con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battaglia di Quebracho. Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche ecc. Poteva ricostruire tutti i sogni dei suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia”.
“Questi, non dimentichiamolo, era quasi incapace di idee generali, platoniche. Non solo gli era difficile comprendere come il simbolo generico “cane” potesse designare un così vasto assortimento di individui diversi per dimensioni e per forma; ma anche l’infastidiva il fatto che il cane delle tre e quattordici (visto di profilo) avesse lo stesso nome del cane delle tre e un quarto (visto di fronte)”.
La sua portentosa capacità di memorizzare ogni dettaglio rende Funes quasi una creatura mitica, (“Ireneo aveva diciannove anni; era nato nel 1868; mi parve monumentale come il bronzo, ma antico come l’Egitto, anteriore alle profezie e alle piramidi”) , ma ogni ricordo sottende dolore poiché:“Funes discerneva continuamente il calmo progredire della corruzione, della carie, della fatica. Notava i progressi della morte, dell’umidità. Era il solitario e lucido spettatore d’un mondo multiforme, istantaneo e quasi intollerabilmente preciso […]Gli era molto difficile distrarsi dal mondo; Funes, sdraiato sulla branda, nel buio, si figurava ogni scalfittura e ogni rilievo delle case precise che lo circondavano”.
Il racconto del narratore è, volutamente, fatto di dettagli, agganci temporali e ricordi, tuttavia, ciò è nulla se paragonato alle infinite possibilità di Funes. La memoria, essenza della storia, pone, al contrario, Funes al di fuori della storia stessa, senza poter stabilire un rapporto con il proprio tempo e spazio. Egli contraddice la storia nel suo aspetto evolutivo ed in tal senso l’immobilità fisica di Funes, dopo essere stato travolto da un cavallo, si trasforma in immobilità di pensiero, in incapacità di comprensione ed empatia per il prossimo.
La condanna di chi, come Funes el Memorioso, ricorda tutto
Si ritiene che uno dei presupposti della memoria e dell’apprendimento sia la selezione delle informazioni da ricordare. Perché, se non c’è dimenticanza, neppure può esserci la memoria. Se ricordassimo ogni istante della nostra vita, saremmo ossessionati dai dettagli e vivere ci sarebbe praticamente impossibile.
Luis Borges su questo argomento ci ha scritto uno dei suoi racconti più citati, Funes El Memorioso (Funes o della memoria, in italiano), che in Italia è stato pubblicato da Adelphi nel volume Finzioni. In questo racconto Funes è un giovane uruguayano dotato di tale memoria da divenire quasi stupido, perché incapace di pensare, in quanto «nel mondo sovraccarico di Funes, non c’erano che dettagli, quasi immediati». Questa folla sterminata di memorie gli uccide la mente, tanto da isolarlo dal resto del mondo, rendendolo solo e incapace di interagire con qualsiasi altro essere umano. E, in definitiva, di vivere.
Nel racconto di Borges, Funes, che non può dimenticare nulla, non ha neppure veri ricordi, ma solo un ammasso di memorie che gli affannano la mente. Oggi sappiamo che persone affette da una sindrome come quella di Funes esistono davvero e che, per quanto spaventosa sia questa condizione, vivere è possibile, nonostante si tratti di un’esistenza molto diversa rispetto a quella vissuta della maggior parte di noi.
Ad esempio, conosciamo la storia di Rebecca Sharrock, una ragazza australiana affetta da sindrome ipertimesica. In compagnia di sole altre ottanta persone in tutto il mondo a cui è stata diagnosticata la Highly superior autobiographical memory, Rebecca ricorda ogni dettaglio della sua esistenza a partire dai dodici giorni di vita. Della sua biografia non ricorda solo gli avvenimenti, ma anche le sensazioni, come se le vivesse in questo momento: i sapori, gli odori, i piaceri, ma purtroppo anche i dolori. Tanto che, per riuscire a dormire, deve tenere accesa la radio, per farsi distrarre dall’ondata di memorie che altrimenti la verrebbe ad angosciare ogni volta.
Sebbene da qualche anno Rebecca Sharrock sappia di avere solo una memoria prodigiosa, e non un altro disturbo fisicamente molto più compromettente, la sua vita è molto diversa da quella di tutti noi. Oltre a conoscere a memoria pagina per pagina ogni libro di Harry Potter, i ricordi che ha vissuto tornano a trovarla senza che lei possa fermarli. Questa impossibilità di oblio rappresenta, senza dubbio, una forma di condanna, che in parte ha a che fare con l’impossibilità di viveve appieno il presente e di progettare serenamente il futuro.
La maggior parte di noi ha alle spalle un’esperienza molto diversa da quella di Rebecca Sharrock, così come da quella di Funes el memorioso, ma la loro condizione porta alla luce un argomento su cui ognuno di noi ogni tanto dovrebbe riflettere: quanto ci blocca il passato? È possibile che alcuni episodi conclusi da molto tempo ci ancorino a una dimensione che ci sta impedendo di andare avanti, di rinnovarci, di rifiorire? E quanto dovremmo dimenticare, o addirittura perdonare, di quel passato per sentirci liberi di affrontare il futuro? Diceva il filosofo Nietzsche che «la felicità è l’oblio», che ovviamente è un’affermazione paradossale, ma anche una grande verità: per poter andare avanti abbiamo infatti bisogno di dimenticare – o, meglio, elaborare – in parte il passato, soprattutto quello che fa male e che ci blocca, ma nello stesso tempo di abbandonarci anche alla fantasia di un futuro che ancora non c’è. Per questo un buon equilibrio tra memoria e oblio rappresenta la via per la felicità: bisogna saper selezionare ciò che è ci è utile da ciò che invece ci ancora al passato; bisogna insomma avere la capacità di ricordare per sapere chi siamo, associata alla facoltà di dimenticare per poter immaginare ciò che potremmo ancora essere: questa è la chiave per una cosciente costruzione della nostra vita. Un obiettivo che il povero Funes di Borges, la cui mente era sovraffollata di ricordi, certo non poteva permettersi.

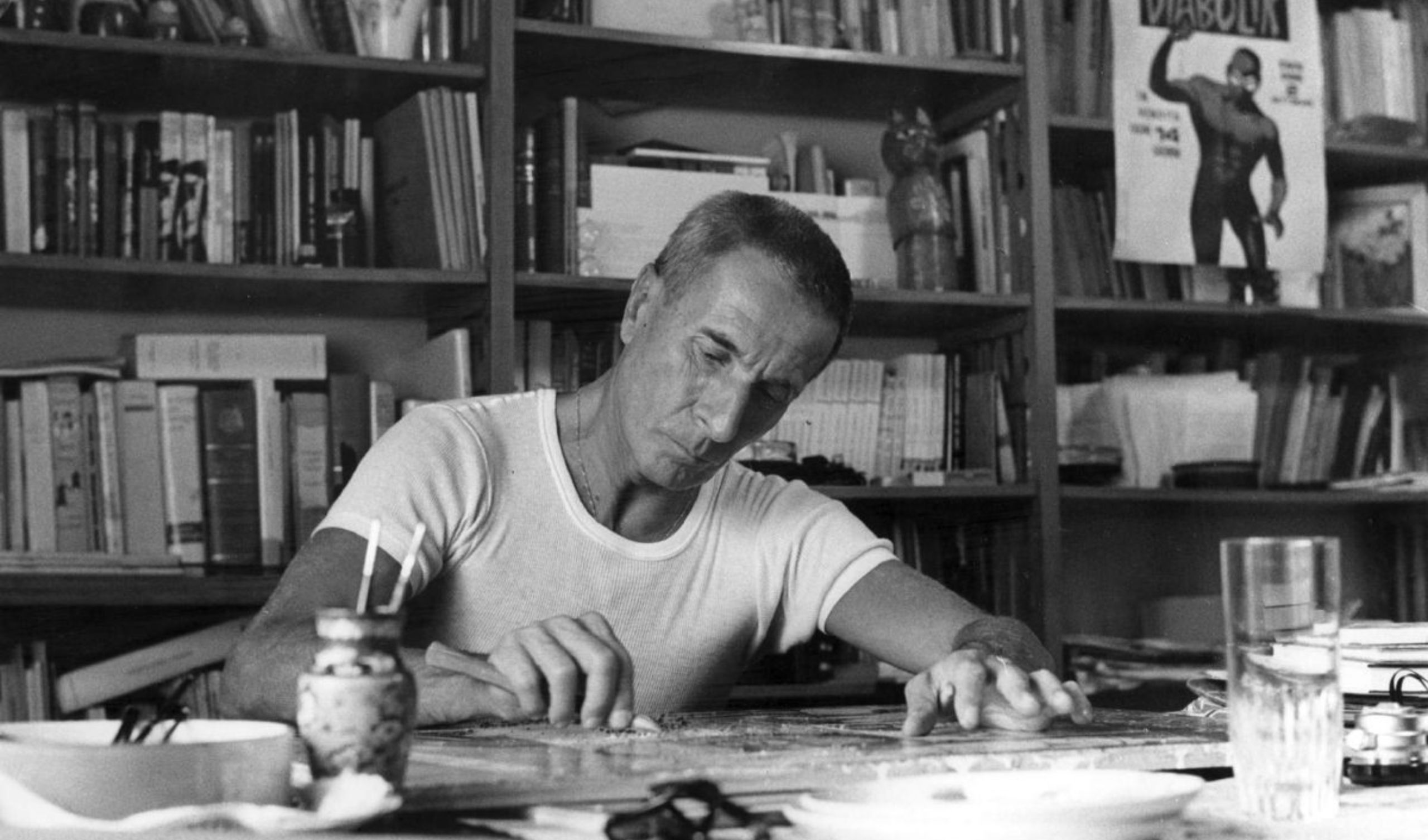
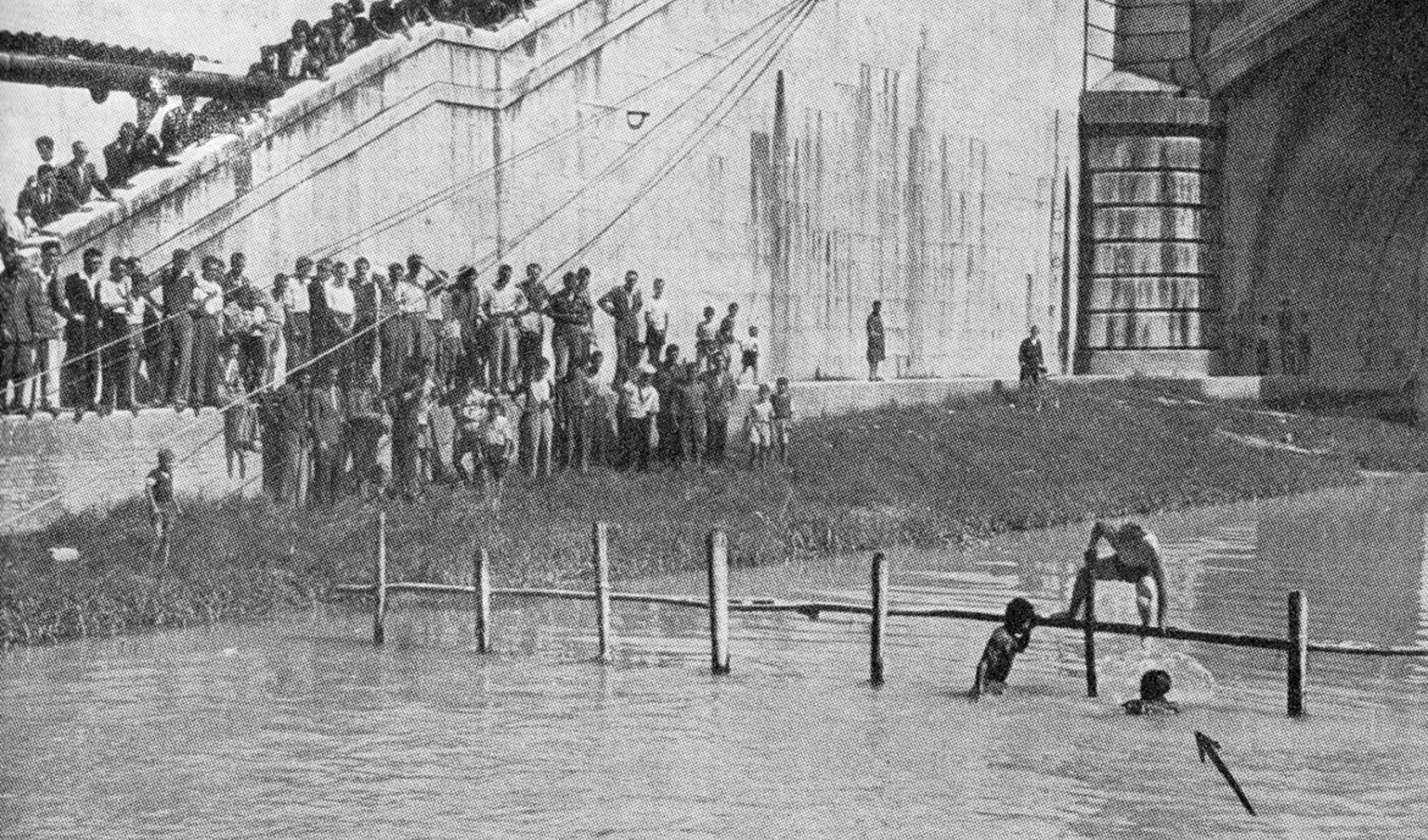





 Users Today : 11
Users Today : 11 Total Users : 270173
Total Users : 270173 Who's Online : 1
Who's Online : 1